Ogni essere umano vive di speranza
Il coraggio e la paura 19.04.2025 Vito Mancuso Tradotto da: Jpic-jp.orgPapa Francesco ha messo come slogan dell’anno giubilare “Pellegrini della speranza”; per i cattolici la speranza una virtù teologale, dando la falsa impressione che è attribuibile solo ai cristiani; in realtà ogni essere umano vive “ne ha una e vive di essa”. E’ il punto di vista di un filosofo.

Ogni essere umano ne ha una e vive di essa, visto che noi siamo i nostri desideri e che l’insieme dei desideri costituisce la meta verso cui tendiamo, la quale appunto si può denominare speranza; ciò però che fa di questa speranza una virtù è la speranza nel bene, nella possibilità di una cambiamento reale a favore di una maggiore giustizia. Il valore di un essere umano e del suo pensiero si misura anche da qui.
Non a caso Kant collocò la speranza tra i tre oggetti per eccellenza del pensiero, insieme al sapere e all’etica, come si legge in un passo della Critica della ragion pura che presenta le tre domande fondamentali che ogni essere umano dovrebbe porre a se stesso: “Ogni interesse della mia ragione (tanto lo speculativo che il pratico) si concentra nelle tre domande che seguono: 1.- Che cosa posso sapere? 2-. Che cosa debbo fare? 3-. Che cosa mi è lecito sperare?” L’uso della prima persona singolare segnala che qui non sono in gioco disquisizioni accademiche, ma l’esistenza concreta qui e ora alla ricerca di un senso per cui, e di cui vivere. Successivamente Kant riformulò il pensiero come segue: “Il campo della filosofia può ricondursi ai seguenti problemi: 1-. Che cosa posso sapere? 2-. Che cosa debbo fare? 3-. Che cosa posso sperare? 4-. Che cosa è l’uomo? Alla prima domanda risponde la metafisica, alla seconda la morale, alla terza la religione, alla quarta l’antropologia. Ma, in fondo, tutta questa materia potrebbe essere ascritta all’antropologia, perché i primi tre problemi si riferiscono al quarto”.
Si tratta quindi ultimamente di antropologia, ma non come disciplina accademica, bensì come questione esistenziale che la situazione limite intuisce qui e ora per la coscienza di ognuno: tu, che essere umano sei? La nostra identità non è statica ma dinamica, e cioè determinata dalla nebulosa di bisogni-desideri-aspirazioni che richiamano il nostro caos interiore conferendogli direzione e forma. La nostra più vera identità è data dalla nostra speranza. E quindi, quando cambia un essere umano?
Un essere umano cambia quando cambiano i suoi desideri la cui somma si chiama speranza, i quali, invece di tendere verso i bisogni, salgono e divengono aspirazioni, così che, invece di sentire il desiderio irrefrenabile dell’ennesimo paio di scarpe o di una borsa o di una camicia, o di una carica o di un riconoscimento o di un applauso, inizia a sentire il desiderio di meno scarpe, meno borse, meno camicie, meno cariche, meno riconoscimenti, meno applausi, meno tutto, solo cose vere, per favore, solo cose e persone vere, per favore: musiche vere, pagine vere, amici veri, relazioni vere. Vita autentica.
Ho letto da qualche parte che secondo Isidoro di Siviglia, un dotto del vii secolo esperto in etimologie, il termine speranza, in latino spes, viene da pes, piede; fondata o no, l’etimologia è suggestiva: la speranza è ciò che fa camminare nella vita. Senza speranza non si cammina. Una celebre pagina di Eschilo du Prometeo, il titano che rubò il fuoco agli dei per donarlo agli uomini, lo conferma. Mentre si trovava incatenato su un monte del Caucaso per ordine di Zeus, con un aquila che durante il giorno gli mangia il fegato che poi di notte ricresce, una corifea gli chiede il motivo di quella sua condizione e Prometeo le risponde di essere stato punito per aver avuto pietà degli esseri umani: “Gli uomini avevano sempre, fissa, davanti agli occhi la morte: io ha fatto cessare quello sguardo”. La corifea gli domanda: “E quale rimedio hai trovato per questo male?”. Risposta: “Ho fatto abitare dentro di loro le cieche speranze”. Solo a questo punto Prometeo aggiunge: “E poi procurai a loro il fuoco”.
Prima di dare agli uomini il fuoco, Prometeo diede loro le speranze, che sono dette cieche non perché fatue, ma per definizione: la speranza infatti non vede come andrà a finire. E’ cieca, tuttavia è forte e conferisce forza, al punto che lo stesso utilizzo del fuoco richiede la sua presenza per la fiducia nella possibilità che il lavoro sia fruttuoso.
La speranza è da sempre connessa all’essenza dell’umanità, come insegnano Eschilo, Kant e le tradizioni spirituali. Speranze e fuoco, fiducia e tecnica, sapienza e scienza, devono tornare a essere strettamente connesse nella società e, ancor prima, nell’esistenza di ognuno di noi.
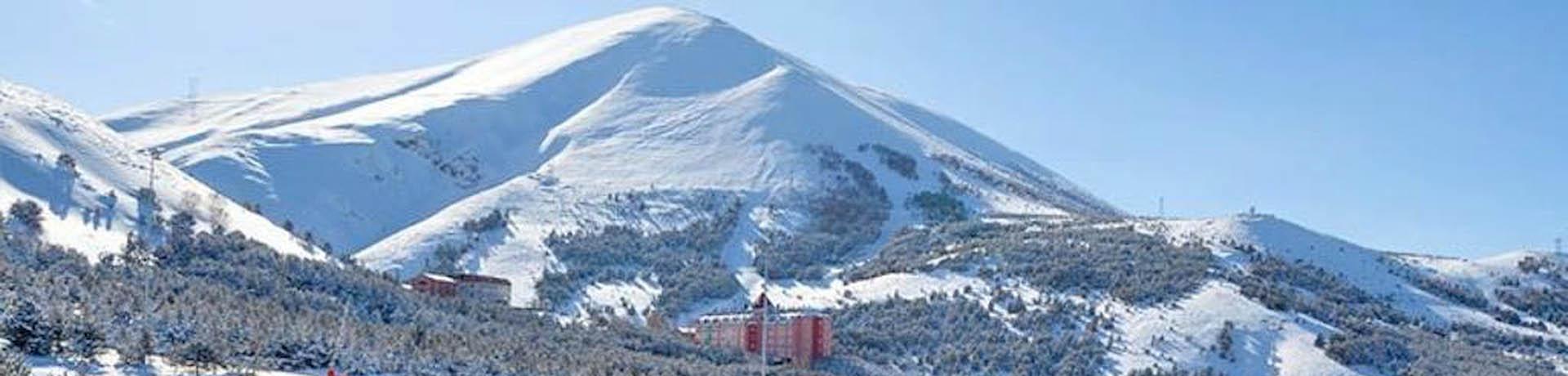






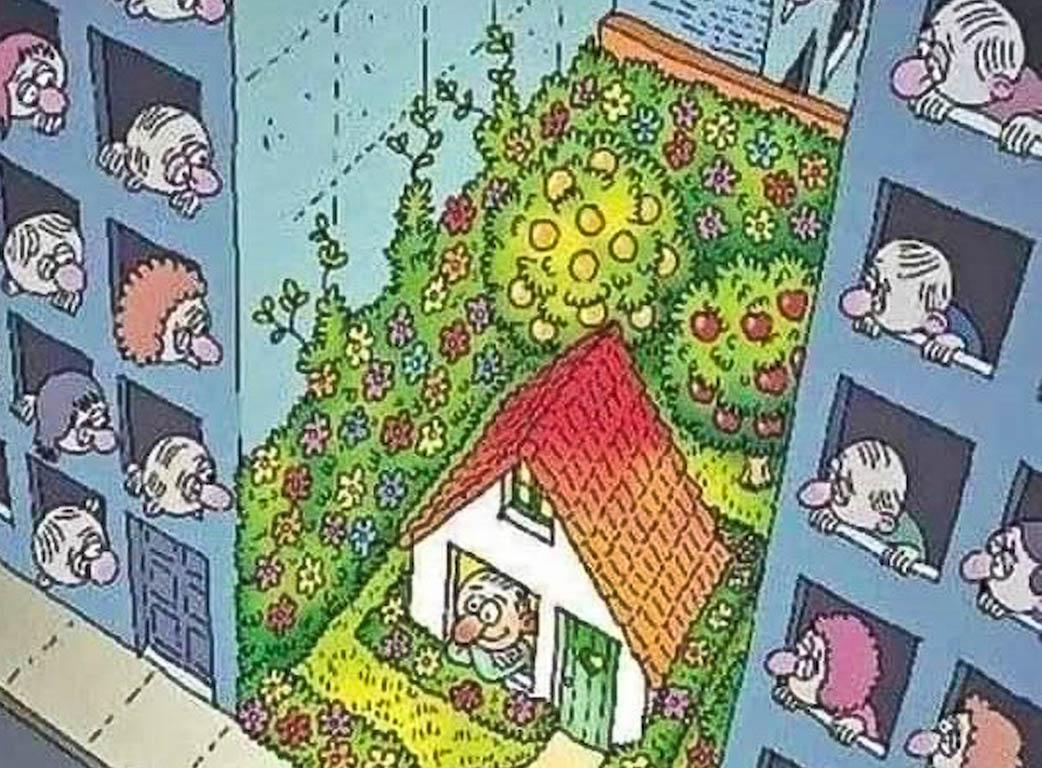
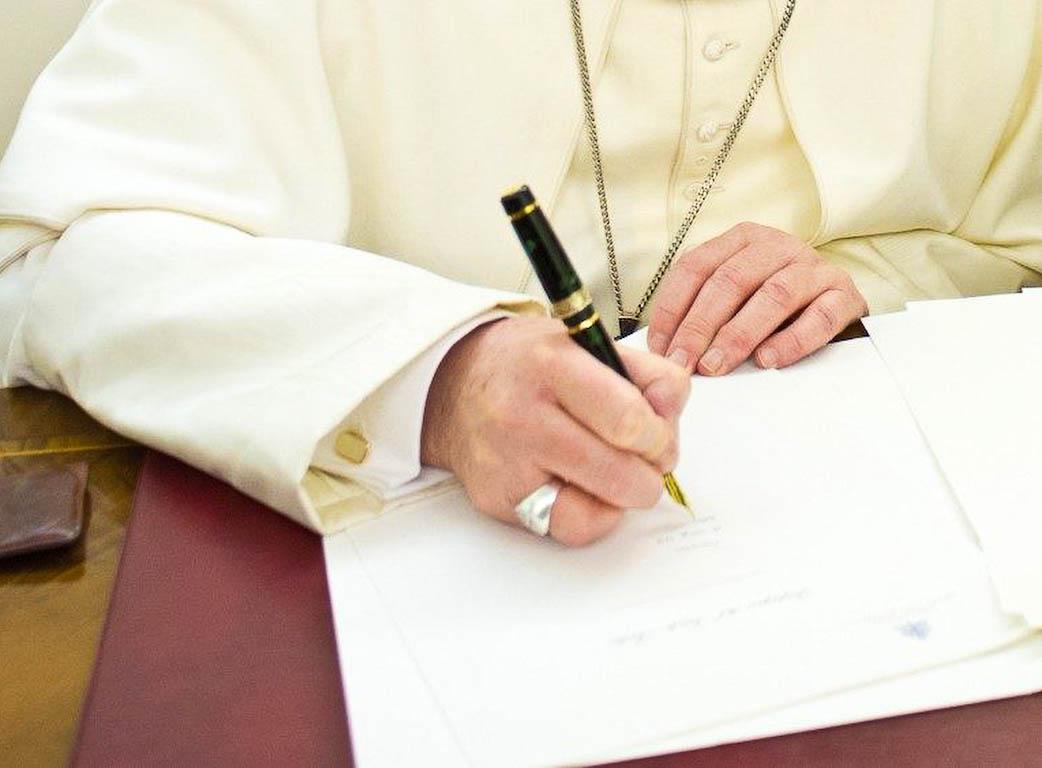






 EDitt | Web Agency
EDitt | Web Agency
Lascia un commento